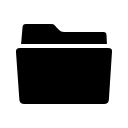
V (1)
Virtù s.f. [gr. ἀρετή- lat. virtus ], propensione a fare il bene per se stesso, senza attendersi alcun utile, sia nella vita privata sia in quella pubblica; eccellenza di qualità predicabile dall’uomo. È capacità di una persona di eccellere in qualcosa, di compiere un certo atto in maniera ottimale, di essere virtuoso come "modo perfetto d'essere".
Secondo Platone la virtù costituisce il cardine dell'etica e delle sue trasformazioni nel corso del tempo, che corrispondono al controllo della parte razionale dell'anima sulle passioni.
Nella Repubblica sono elencate per la prima volta le virtù che invitano l’uomo di condurre una vita, sia essa privata sia essa pubblica, ispirata alla saggezza.
Sono le seguenti: la temperanza, consistente nella moderazione dei desideri; il coraggio, necessario per mettere in atto i comportamenti virtuosi; la saggezza, variamente intesa dalla speculazione antica come controllo delle passioni; la giustizia, cioè accordo armonico ed equilibrato di tutte le altre virtù.
Esse riguardano la vita pratica di chi è disposto al bene per se stesso, senza arrogarsi meriti o diritti di qualsiasi genere.
In contrapposizioni alle virtù etiche ci sono le virtù danoetiche che Aristotele tratta nel rispetto dei passaggi che seguono.
Anzitutto esse sono intellettive, razionali dell’anima concupiscibile. Secondo Aristotele [Etica Nicomachea 1,102b- 1103a- VI, 3, 1139 b- 1141b] vi è una gerarchia tra le virtù, e quelle intellettive sono superiori a quelle morali. Le virtù dianoetiche sono le seguenti: l’arte (τέχνη), la scienza (ἐπιστήµη), la saggezza pratica (φρόνησις), l’intelletto (νοῦς) e la sapienza (σοφὶα).
L’attività spirituale dell’uomo è triplice e consiste nel creare (ποιεῖν), operare (πράσσειν), conoscere (ϑεωρεῖν): al creare corrisponde la virtù dell’arte, all’operare la prudenza, al conoscere il sapere (o scienza) e l’intelletto.