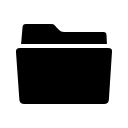
A (7)
Accidènte s. m. [gr. συµβεβηκος- lat. accĭdens ], caso, avvenimento non previsto; ciò che accade fortuitamente, senza una ragione apparente.
In filosofia, ciò che appartiene a un oggetto [ente] in modo casuale, o anche per se stesso, o anche necessariamente, ma senza però far parte della sua essenza. Il contesto in cui si colloca questa nozione è nello studio degli enti.
L’accidente ha acquisito un significato tecnico con Aristotele che lo definisce in Topici I, 5 in questo modo: “Non è né la definizione, né il carattere proprio né il genere, ma appartiene all’oggetto, o anche, è ciò che può appartenere o non appartenere a un solo e medesimo oggetto, qualunque esso sia".
Nello studiare l’identificazione della sostanza di un ente, per darne una definizione reale, Aristotele crede che alcuni caratteri dell’ente studiato si trovino in una di queste posizioni:
- gli appartengono per caso, non necessariamente, e quindi né sempre né per lo più, ma solo talvolta.
- gli appartengono necessariamente, ma non fanno parte della sua essenza , ciò significa che l’ente non cambia con il variare di questi suoi caratteri.
Allegoria s.f. (dal gr. ἀλλεγορία, da ἄλλος "altro" e ἀγορεύω "parlo"). Similitudine figurata per rappresentare qualcosa di difficile da comprendere in altro modo. In filosofia è assimilabile al mito. Esempio di allegoria o metafora sublime è quella della Caverna, proposta da Platone nel Libro VII di Repubblica.
Amore s.m. (dal lat. amor, dal gr. Ἔρως), Secondo Platone, anelito d’immortalità, di perfezione morale, di conoscenza delle idee e del bene. Più in generale nella cultura greca è ciò che fa muovere verso qualcosa;un principio divino che spinge verso la bellezza.
Anima s. f. [lat. anĭma, affine, come anĭmus, dal gr. ἄνεμος «soffio, vento»]. – Nell’accezione più generica, il principio vitale dell’uomo, di cui costituisce la parte immateriale, origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della stessa coscienza morale. Più in generale principio vitale dehli esseri. Anima è vegetativa per le piante, sensitiva per gli animali, razionale per gli uomini. È la parte spirituale dell’uomo per cui egli pensa e opera.
Apeiron, [gr.ἄπειρων], infinito, illimitato, indeterminato, immenso. Nei dizionari di lingua greca si segnala come aggettivo, ma forse il termine, nel suo significato originario di Infinito diventa sostantivo di genere neutro o aggettivo sostantivato. Il concetto e il termine stesso sono stati ideati da Anassimandro.
Egli riteneva che in origine tutte le cose fossero armoniosamente unite nell'ápeiron [infinito], ma a causa di una colpa originaria, non meglio specificata, le cose si separarono in coppie di contrari, [luce-tenebra, notte-giorno, vita-morte] dando origine al cosmo.
aporia s. f. [gr. ἀπορία- lat. aporia], dubbio, incertezza, imbarazzo; strada senza uscita, passaggio impraticabile. Nella filosofia greca l’aporia indicava l'impossibilità di dare una risposta precisa a un problema, poiché ci si trovava di fronte a due soluzioni che, per quanto opposte, entrambe valide.
Un esempio sull’argomento riguarda la materia estesa, limitata nello spazio ma divisibile fino all’infinito. Per quanto piccola sia la parte ottenuta dalla divisione essa, essendo materiale e quindi estesa, la sua divisibilità tende all’infinito.
Anassagora sosteneva la teoria dei semi infiniti, particelle originarie divisibili all'infinito. Partendo da questo presupposto Democrito si pose la domanda: Com’è possibile allora che ci siano oggetti finiti? Le cose finite non possono avere luogo nell’infinito. Da qui la necessità di pensare che vi siano particelle materiali, originarie ma non più divisibili, cioè gli atomi.
Conclusione: divisibilità della materia all'infinito e non divisibilità della materia all'infinito si oppongono, ma razionalmente sono valide entrambe.