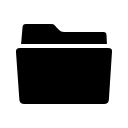
M (2)
maièutica s. f. [gr. μαιευτική τέχνη, lett. arte ostetrica]. Il termine si riferisce a una tecnica di ricerca della verità attraverso la sollecitazione del soggetto pensante verso il probabile uditorio di piazza. Nel Teeteto, Socrate, il quale, secondo Platone, si è comportato come un’ostetrica aiutando gli altri a partorire la verità. Socrate equipara il proprio metodo filosofico al mestiere dell’ostetrica, che assiste la partoriente. Solo che la nascita a cui egli allude non si riferisce al corpo, ma nell’anima.Attraverso la sua dialettica Socrate aiuterà i giovani, desiderosi di conoscenza, a partorire nuove idee, in cammino verso la conoscenza della verità, senza insegnare loro nulla, ma facendo in modo che siano essi stessi a elaborarle. La metafora è legata al rifiuto socratico di insegnare ad allievi, al suo “ so di non sapere”e alla sua interpretazione dell’antico motto delfico “ Conosci te stesso!”.
Monismo, s.m. [ dal gr. μόνος ], il termine è stato coniato assai recentemente per indicare in filosofia un unico principio o sostanza, materiale o spirituale, contrapposto a ogni forma di dualismo, riducendo la pluralità degli esseri a un’unica sostanza, o essere, staticamente o dinamicamente inteso.
La scuola di Mileto, agli albori della filosofia, sosteneva che l’acqua fosse l’unica causa materiale, origine del tutto. Parmenide [VI-V secolo a.C.], conferì all’essere l’origine del tutto, escludendo il non essere, servendosi della formula seguente:
| «ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι ἡ δ' ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι» | « È e non è possibile che non sia È ed è necessario che non sia» |
L’esclusione del non essere fu causa di una vera e propria rivoluzione filosofica, sollevata da chi identificava il Principio o Causa Prima con una sostanza materiale e anche da chi la identificava in un principio immateriale.
I filosofi ateniesi criticarono aspramente il principio eleatico dell’essere e del non essere. “Com’è possibile, sostenevano i critici, concepire l’essere non avendo l’esatta cognizione del non essere? È del tutto evidente che quella locuzione nasconde una palese coppia di opposti, nell’ esempio di luce e ombra, di giorno e notte, e via dicendo.
Già Anassimandro aveva chiamato in gioco gli opposti, che costituivano la diretta conseguenza del conflitto fra gli elementi primari del cosmo, quali notte-giorno, luce-ombra, e via dicendo.
Com’è possibile, sostenevano altri critici, avere cognizione dell’uno senza metterlo a confronto con il molteplice?
Il monismo parmenideo dunque annuncia il significato storico delle famose argomentazioni di Zenone, in difesa di Parmeniude, contro la molteplicità dello spazio, del tempo e di tutti gli altri elementi che formano il cosmo.